
| L'informazione non è un optional, ma è una delle condizioni essenziali dell'esistenza dell'umanità. La lotta per la sopravvivenza, biologica e sociale, è una lotta per ottenere informazioni. |
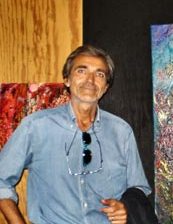
Una campagna lanciata da Amnesty International Italia per non permettere che l'omicidio del giovane ricercatore italiano finisca per essere dimenticato, per essere catalogato tra le tante "inchieste in corso" opeggio, per essere collocato nel passato da una "versione ufficiale" delgoverno del Cairo. Qualsiasi esito distante da una verità accertata e riconosciuta in modo indipendente, da raggiungere anche col preziosocontributo delle donne e degli uomini che in Egitto provano ancora aoccuparsi di diritti umani, nonostante la forte repressione cui sonosottoposti, dev'essere respinto.
"Dobbiamo tenere alta l'attenzione affinché questa vicenda non vengarimossa dall'agenda politica. È una cosa che non possiamo permetterci, per
Giulio, i suoi familiari, per la libertà di ciascuno, ma anche per la dignità del nostro paese" ha dichiarato Antonio Marchesi, presidente diAmnesty International Italia.
In un rapporto pubblicato già nel giugno del 2015, Amnesty Internationalha dichiarato che la continua repressione delle autorità egiziane contro i
giovani attivisti rappresenta il chiaro tentativo di schiacciare le mentipiù coraggiose e brillanti del paese ed eliminare qualunque minacciaembrionale al potere.
"Generazione carcere: la gioventù egiziana dalle proteste alla prigione"
si concentra sui casi di 14 delle migliaia di giovani arrestati in modoarbitrario, detenuti e incarcerati in Egitto negli ultimi due anni inrelazione alleproteste.
Nel suo rapporto, Amnesty International denuncia come il paese sia tornatocompletamente a essere uno stato di polizia. Due anni dopo l'estromissione
del presidente Mohamed Morsi, alle proteste di massa sono subentratiarresti di massa. Attaccando senza sosta i giovani attivisti egiziani, leautorità stanno spezzando le speranze in un futuro migliore di un'interagenerazione.
Per maggiori informazioni sulla campagna di Amnesty International "Verità
per Giulio Regeni" e l'elenco delle adesioni in continuo aggiornamento:
Le denunce e le iniziative di AMNESTY INTERNATIONAL
Quando si esamina criticamente il modo in cui la macchina dell'informazione affronta i vari aspetti problematici del mondo contemporaneo, si finisce assai
spesso per trovarsi amaramente costretti a parlare di evidenti quanto irritanti fenomeni di "strabismo" e di "doppiopesismo". Solo ad alcune cose, cioè, si concede massimo rilievo, mentre altre restano ignorate, solo alcune vengono percepite come degne di discussione, di mobilitazione e di intervento, altre restano in un angolo, senza il privilegio della luce dei riflettori ...
Il caso della guerra in Yemen è, a questo proposito, uno dei casi più emblematicamente macroscopici.
Dal primo attacco aereo dell'Arabia Saudita contro il gruppo armato huthi (25 marzo 2015), è oramai trascorso un intero anno. Da allora, si è sviluppato un conflitto in cui tutte le parti coinvolte hanno commesso numerose violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, compresi anche possibili crimini di guerra.
In questo terribile anno di guerra, sono stati uccisi più di 3.000 civili, fra cui ben 700 bambini, e almeno due milioni e mezzo di individui sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni.
Tutto ciò mentre USA e Regno Unito - principali fornitori di armi all'Arabia Saudita, paese guida della coalizione - nonché altri stati, fra cui lItalia, hanno proseguito ad autorizzare trasferimenti delle armi che hanno reso possibile produrre una gravissima crisi umanitaria, nella quale almeno l' 83 per cento della popolazione si e' venuta a trovare in una condizione di disperato bisogno di aiuti umanitari.
Dall'inizio del conflitto, Amnesty International ha potuto documentare almeno 32 attacchi aerei da parte della coalizione diretta dall'Arabia Saudita, attacchi che, oltre che uccidere numerosi civili, fra cui sicuramente più di cento bambini, hanno colpito ospedali, scuole, mercati e moschee.
"I partner internazionali dell'Arabia Saudita hanno gettato benzina sul fuoco - ha affermato James Lynch, vicedirettore del programma Medio Oriente e Africa del Nord di Amnesty International - sommergendo la regione di armi nonostante fosse sempre più evidente che quelle armi stavano facilitando il compimento di crimini agghiaccianti e che successive forniture avrebbero potuto essere usate per commetterne altri. Ma non solo: quei paesi non hanno neanche saputo istituire una commissione d'indagine indipendente e internazionale sulle violazioni che hanno devastato migliaia di vite di civili."
"Ora - ha aggiunto Lynch - è il momento che i leader mondiali la smettano di mettere gli interessi economici al primo posto e che il Consiglio di Sicurezza imponga un embargo totale ai trasferimenti di armi destinate ad essere usate nello Yemen."
In occasione del doloroso anniversario dell' inizio del conflitto, Amnesty International Italia, al fine di tentare di richiamare l'attenzione su una tragedia tanto generalmente ignorata, ha promosso a Roma due incontri pubblici di approfondimento, avvalendosi, in particolar modo, della presenza di Donatella Rovera, ricercatrice internazionale che negli ultimi venti anni ha guidato missioni di ricerca, documentando violazioni dei diritti umani in numerose situazioni di crisi nelle aree di conflitto piu' pericolose al mondo.
Questi gli appuntamenti:
GIOVEDI' 31 MARZO, ALLE ORE 18,30, PRESSO IL MAXXI -MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO (CORNER D, VIA GUIDO RENI, 4 A), si terra' l'incontro
"Un anno di guerra nello Yemen: le responsabilita' della comunita' internazionale";
VENERDI' 1 APRILE, ALLE ORE 10.15, PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE (SALA DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, VIA OSTIENSE,159)
Donatella Rovera terra' la conferenza "Human rights analisys in crisis countries: methodology and stories by Amnesty International".
La campagna promossa da Amnesty International (in collaborazione con Repubblica) per richiedere in tempi rapidi e con procedure corrette e trasparenti piena chiarezza in merito all'omicidio di Giulio Regeni continua a raccogliere numerose adesioni, fra cui quella della nostra Free Lance International Press.
Quello che si teme è che ci si possa accontentare di accomodanti “verità di Stato” confezionate con il palese obiettivo di spegnere il prima possibile i riflettori, facendo precipitare la dolorosa vicenda negli archivi del passato. Per impedire che ciò possa verificarsi, l'Associazione umanitaria si sta rivolgendo a enti locali, comuni, università, centri di cultura, associazioni della società civile e singoli cittadini, allo scopo di promuovere un vasto movimento di opinione volto al raggiungimento di una verità accertata e riconosciuta in maniera indipendente.
Fra le tante adesioni, oltre ai numerosi messaggi di sostegno sui social network, da parte di singoli cittadini e di personalità del mondo della cultura e della politica: RAI “Uno Mattina” Il Manifesto, Rai Radio 2 “Caterpillar”, le sigle sindacali CGIL, CISL, UIL unitariamente e la Federazione Nazionale Stampa Italiana.
Dopo raffiche di ipotesi balorde (incidente stradale, delitto a sfondo sessuale, ecc.), anche le ultime ipotesi proposte continuano a non convincere nessuno. Non convince né quella che fa riferimento a mere “attività criminali”, né quella lumeggiata dal ministero dellInterno egiziano tramite l'agenzia di  stampa di Stato Mena, secondo cui, tra le varie possibilità, ci potrebbe essere quella di un “desiderio di vendetta per motivi personali, soprattutto perché litaliano aveva avuto legami con persone vicino a dove viveva e studiava.” Né convince maggiormente la tesi del presidente Abdel Fattah Al Sisi, secondo cui la morte del ricercatore sarebbe nata dal desiderio di “colpire le relazioni tra Egitto e Italia.”
stampa di Stato Mena, secondo cui, tra le varie possibilità, ci potrebbe essere quella di un “desiderio di vendetta per motivi personali, soprattutto perché litaliano aveva avuto legami con persone vicino a dove viveva e studiava.” Né convince maggiormente la tesi del presidente Abdel Fattah Al Sisi, secondo cui la morte del ricercatore sarebbe nata dal desiderio di “colpire le relazioni tra Egitto e Italia.”
Hanno tutte il sapore nauseabondo ed irritante degli innumerevoli tentativi di depistaggio già tante volte registrati nella storia lontana e recente (anche in quella delle nostre “mura di casa”) ...
Un saporaccio tale da indurre lo stesso ministro Gentiloni a parlare di “ipotesi improbabili”.
Intanto, dall'Egitto, arrivano altre pessime notizie: il 17 febbraio le forze di sicurezza hanno imposto la chiusura della sede del Centro EL NADEEM per la riabilitazione delle vittime della violenza, nella capitale Il Cairo. Il Centro, riconosciuto nel 1993, ha potuto fornire assistenza legale e consulenza psicologica fondamentali a centinaia di vittime di tortura. Imporne pertanto la chiusura non può che apparire come un'ulteriore fase della repressione contro le attiviste e gli attivisti per i diritti umani.
“Il Centro El Nadeem per la riabilitazione delle vittime della violenza ha costituito un'ancora di salvezza per centinaia di vittime della tortura e per le famiglie di coloro che sono stati sottoposti a sparizione forzata. Siamo di fronte al tentativo di chiudere un'organizzazione che e' stata un bastione della difesa dei diritti umani e una spina nel fianco delle autorità per oltre 20 anni” - ha dichiarato Said Boumedouha, vicedirettore del programma Medio Oriente e Africa del Nord di Amnesty International. “Le autorità devono sospendere l'ordine di chiusura del Centro e fornire un'esauriente spiegazione delle ragioni che lo hanno determinato. Il Centro deve avere l'opportunità di contestare l'ordine di chiusura di fronte a un tribunale” - ha aggiunto Boumedouha.
Sempre più disumano il conflitto nello Yemen.
La guerra in Yemen continua, nella disattenzione quasi generale, a produrre vittime ed atrocità. E continua anche a colpire chi le vittime cerca di soccorrerle.
In Yemen, Medici Senza Frontiere sta lavorando nei governatorati di Aden, Al- Dhale, Taiz, Saada, Amran, Hajjah, Ibb e Sana'a. Sin dall'inizio della crisi in corso, nel marzo 2015, le équipes di MSF hanno curato più di 20.000 feriti di guerra, inviando più di 790 tonnellate di materiale medico e riuscendo a gestire 11 ospedali e centri sanitari, supportandone regolarmente diciotto. In questo modo, con un sistema sanitario alquanto deficitario, MSF fornisce, di fatto, anche servizi sanitari non di semplice emergenza.
Ma il conflitto in Yemen, che si sta combattendo con un sempre più evidente disprezzo per le regole di guerra previste a livello internazionale, ha finito per attaccare le attività mediche di MSF in Yemen ben quattro volte in meno di tre mesi, con conseguenze di crescente gravità.
“Il modo in cui si combatte in Yemen sta arrecando enormi sofferenze e dimostra che le parti in conflitto non riconoscono e non rispettano lo status protetto di ospedali e strutture sanitarie. Ne vediamo le conseguenze devastanti ogni giorno sulle persone intrappolate nelle zone di conflitto”, dichiaraRaquel Ayora, direttore delle operazioni di MSF. Da quando è scoppiato il conflitto,infatti, i luoghi pubblici vengono colpiti e bombardati su vasta scala. Nulla viene risparmiato, nemmeno gli ospedali, anche se le strutture mediche sono esplicitamente protette dal diritto internazionale umanitario e nonostante le puntuali e circostanziate comunicazioni relative alle coordinate della loro.ubicazione.
Il primo attacco verificatosi in questi ultimi mesi ha avuto luogo il 26 ottobre, quando gli aerei della Coalizione guidata dall’Arabia Saudita hanno ripetutamente bombardato un ospedale nel distretto di Haydan, nella Provincia di Saada, lasciando almeno 200.000 persone prive di cure mediche salvavita.
Successivamente, una clinica mobile di MSF è stata colpita il 2 dicembre, nel quartiere Al Houban di Taiz, ferendo otto persone (tra cui due membri del personale) e uccidendo una persona nelle vicinanze.
Il 10 gennaio, l'ospedale supportato da MSF a Shiara è stato attaccato in un incidente che ha ucciso sei persone e ferito almeno sette (la maggior parte di loro personale medico e pazienti), mentre il 21 gennaio un’ambulanza di MSF è stata colpita e il suo conducente ucciso in una serie di attacchi aerei che hanno ferito decine di persone, uccidendone almeno sei nel governatorato di Saada.
MSF ha deciso di appellarsi alla Commissione d’Inchiesta Umanitaria Internazionale (unico organo d'inchiesta internazionale permanente con un mandato specifico per indagare potenziali violazioni del diritto umanitario internazionale, ai sensi delle Convenzioni di Ginevra), richiedendo un'indagine indipendente sull’attacco all’ospedale di Shiara.
MSF si era già rivolta alla Commissione in seguito al bombardamento del proprio ospedale traumatologico a Kunduz, in Afghanistan, da parte dell'esercito degli Stati Uniti, che ancora non si sono espressi in merito alla richiesta di indagini.
“Quattro nostre strutture sanitarie sono state attaccate in quattro mesi in Yemen e in Afghanistan”, dichiara la dott.ssa Joanne Liu, presidente internazionale di MSF. “E’ questa la nuova prassi: un ospedale di MSF bombardato al mese? Quanti altri ospedali sono attaccati in Yemen e in altre zone di conflitto, gestiti da personale medico che non ha la stessa forza di MSF per denunciare all’opinione pubblica quanto sta accadendo? Ci rifiutiamo di accettare che questa tendenza prosegua con una totale assenza di responsabilità. Abbiamo urgente bisogno di garanzie dalle parti in guerra che gli ospedali funzionanti non diventino mai un obiettivo legittimo”.
L’ospedale di Shiara supportato da MSF è soltanto l’ultimo di più di cento centri sanitari e ospedali colpiti da bombardamenti e attacchi aerei durante il conflitto internazionale che sta devastando il Paese ormai da dieci mesi.
Juan Prieto, coordinatore generale dei progetti MSF in Yemen, a proposito della situazione venutasi a delineare nel distretto e nel Paese, ha recentemente affermato che
“Le persone continuano a considerare gli ospedali un bersaglio e provano il più possibile a evitarli. Gli unici casi che stiamo ricevendo sono emergenze e vittime degli attacchi. Finora siamo stati in grado di ripristinare il pronto soccorso e i servizi di trasferimento e di stabilizzazione e ci stiamo sforzando di far tornare operativo il reparto maternità. Stiamo lavorando con uno staff ridotto, concentrandoci solo sui bisogni medici urgenti. La struttura è considerata un luogo pericoloso, non dimenticate che è stata colpita tre volte lo scorso anno. Ciò nonostante, i membri del nostro staff sono tornati ai propri ruoli anche se con apprensione. Sono più determinati che mai, vista la situazione del Paese e gli specifici bisogni nel Razeh, a continuare a lavorare per la popolazione.”
Anche in periodo natalizio, fra i tanti filmini e filmetti in circolazione, ineluttabilmente convergenti nell`indurre al rimpianto del denaro sborsato, puo` capitare di imbattersi in espressioni importanti di cinema vero. E` questo il caso di "Ponte delle spie" di Spielberg. Un film che ricostruisce una pagina ignota quanto avvincente del periodo convenzionalmente denominato "guerra fredda" (pagina relativa ad uno scambio di prigionieri fra USA e URSS) e che, oltre a fornirci un quadro indubbiamente efficace di quel terribile periodo, riesce ad inviarci anche messaggi attualissimi.
Ci dice, infatti, che, sempre e in ogni caso, i principi di umanita` possono essere difesi e salvati e addirittura imposti alla prepotenza delle varie "Ragioni di Stato"; che ci puo` essere sempre spazio per uno slancio empatico, per tendere una mano, per sentirsi responsabili della vita di chi non puo` difendersi; che ci puo` essere sempre una via inesplorata da percorrere, una strategia scompaginante da adottare, per far si` che la fantasia e l`intelligenza riescano ad imporre la prassi del dialogo e del negoziato a quella fin troppo collaudata delle clave e delle bombe.
'Ponte delle spie" e` un film magnificamente realizzato, che ci lascia dentro il sapore denso delle cose ben fatte e il sorriso carezzevole della ragione umana che non sa e che non vuole arrendersi agli schemi reificanti inventati da uomini miopi e stolti per potersi etichettare, maledire e uccidere gli uni con gli altri ...
Da quando, nell’ormai lontano 30 settembre, la Russia ha annunciato formalmente di intervenire nel conflitto armato in Siria, risultano essersi verificati migliaia di attacchi.
Mentre le autorità russe continuano ad affermare (cosa tristemente ricorrente in situazioni di questo genere) che l’aviazione si starebbe limitando a colpire obiettivi legati alle forze dei "terroristi", dal recentissimo rapporto di Amnesty International (https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/3113/2015/en/) gli attacchi russi risultano aver provocato centinaia di vittime civili, di aver distrutto o gravemente danneggiato decine di abitazioni e, addirittura, un ospedale.
Il rapporto dell’organizzazione umanitaria, infatti (intitolato Non sono stati colpiti obiettivi civili. Smascherate le dichiarazioni della Russia sui suoi attacchi in Siria), illustra, con riferimenti schiaccianti, quanto alto sia il prezzo che la popolazione siriana sta pagando a seguito degli attacchi condotti sul proprio territorio, mettendo anche in luce come le autorità russe abbiano fatto ricorso alla menzogna, al fine di occultare gli attacchi effettuati contro una moschea e una struttura ospedaliera da campo.
Inoltre, il rapporto ci informa che si starebbe facendo uso di munizioni vietate dal diritto internazionale, nonché di bombe prive di sistemi di guida, in attacchi contro zone densamente popolate, prive, tra l’altro, di obiettivi militari
A questo proposito, Philip Luther, direttore del programma Medio Oriente e Africa del Nord di Amnesty International, è stato categorico:
“Attacchi del genere costituiscono crimini di guerra. E’ fondamentale che queste violazioni siano oggetto di indagini indipendenti e imparziali”.
In uno dei bombardamenti più rovinosi descritti nel rapporto, ben tre missili hanno centrato il mercato centrale di Ariha (provincia di Idlib), provocando 49 vittime civili.
Un testimoni oculare racconta che
"Nel giro di pochi attimi la gente urlava, c'era puzza di bruciato nell'aria e tutto intorno il caos. C'era una scuola elementare lì vicino e i bambini scappavano terrorizzati... c'erano corpi ovunque, decapitati e mutilati" .
Il testimone racconta anche di aver visto una donna seduta in lacrime davanti a una fila di 40 salme, dopo aver appena perso suo marito e tre figli.
Un altro testimone, invece, riferendosi all’attacco del 7 ottobre, in cui sono stati distrutti numerosi edifici civili a Darat Izza (provincia di Aleppo), ha affermato:
"Era diverso dagli altri attacchi aerei. La terra ha tremato come se ci fosse stato un terremoto... è stata la peggiore distruzione che abbia visto... Una madre e i suoi due figli sono stati uccisi in un'abitazione, una giovane coppia in un'altra: si erano sposati la settimana prima..."
Amnesty International ha anche raccolto prove che attestano l’impiego di armi vietate a livello internazionale, come le bombe a grappolo, bombe che sprigionano piccoli ordigni che si diffondono su un’area di una ampiezza simile a quella di un campo di calcio, molti dei quali, non esplodendo al momento, si trasformano in una minaccia per la popolazione per gli anni successivi.
Secondo le organizzazioni siriane in difesa dei diritti umani, inoltre, i raid aerei russi sulla Siria avrebbero provocato la morte di centinaia di civili che non partecipavano direttamente agli scontri. Dall'inizio delle operazioni fino al 15 novembre, i civili uccisi sarebbero almeno 526, tra i quali 137 bambini e 71 donne. Altre fonti (sempre in ambito umanitario) parlano di 570 civili morti tra il 30 settembre e il 1 dicembre. I bombardamenti dell'aviazione russa, inoltre, avrebbero distrutto o seriamente danneggiato ospedali (dieci solo nel mese di ottobre), decine di case e altri obiettivi civili.
 |
| Putin |
Alla fine del rapporto, Amnesty osserva che la Russia, in quanto parte del conflitto armato in Siria, è tenuta, come le altre parti, ad assicurarsi che il suo esercito rispetti la legislazione internazionale in materia di diritti umani e le leggi che regolano la condotta in guerra, come previsto dai trattati ratificati, incluse le quattro convenzioni di Ginevra del 1949 e il relativo protocollo aggiuntivo. Il principio di distinzione che prevede che tutte le parti in causa distinguano obiettivi militari e civili, dirigendo i propri attacchi solo contro i primi, ha, infatti, come coerente corollario il divieto esplicito di condurre attacchi indiscriminati.
L’autorevole Associazione umanitaria invita pertanto le autorità russe a rispettare le leggi internazionali, assicurandosi che i civili non siano danneggiati, o, almeno, a prendere le dovute precauzioni per ridurre al minimo le vittime civili e la distruzione di case, ospedali, scuole e altri edifici non utilizzati nel conflitto.
Amnesty International chiede inoltre che siano condotte inchieste indipendenti e imparziali sui sospetti casi di violazioni della legislazione internazionale in materia di diritti umani.
Lo scorso anno, durante uno dei miei tanti bellissimi incontri con gli studenti (nelle vesti di attivista di Amnesty International), una bimba di scuola media, alla richiesta di fornire una definizione del concetto di "diritti umani", in maniera immediatissima ha risposto:
"I diritti umani sono la vita!"
La sua risposta mi piacque subito e, ripensandoci, ho deciso che dovrebbe meritare di essere apprezzata almeno quanto quelle, certamente più dotte, donateci dai nostri migliori "addetti ai lavori".
Perché va subito al cuore del problema. Perché centra il bersaglio e coglie perfettamente la sostanza centrale della questione.
Dire, infatti, che i diritti umani coincidono con la vita stessa vuol dire che, senza di essi, la vita sarebbe una non-vita. Che, senza di essi, la vita che ci resterebbe (anzi: che ci verrebbe lasciata) sarebbe un sacco vuoto, un feticcio senza sorriso.
Che, senza di essi, cioè, non sarebbe possibile vivere una vita vera, una vita che sappia davvero di vita, che possa essere ritenuta meritevole di essere, pertanto, desiderata, difesa, amata ...
Che senza di essi, tutte le cose di questo mondo che potremmo avere non riuscirebbero a riempire l'abisso di nulla e di infelicità che si verrebbe ad aprire nella nostra anima ...
Perché i diritti umani sono figli dell'universalmente umana esperienza del dolore. Perché i diritti umani sono creature ribelli della nostra vulnerabilità e della nostra paura. Sono il tentativo di portarci per mano oltre i fiumi di sangue e di lacrime sgorgati dai nostri animi vulnerabili e impauriti. Sono il tentativo di portarci oltre i confini ingabbiati da fossi, da trincee, da muraglie e da chilometriche matasse di filo spinato ...
Sono il tentativo più luminoso costruito nella storia per ricordarci, come afferma Erasmo da Rotterdam, che le nostre fragili mani sono fatte per donare carezze e non per colpire. Per ricordarci, come insegna Aldo Capitini, che la condizione in cui ci troviamo ad esistere oggi, così straripantemente intossicata da ingiustizie ed orrori, è una realtà che non merita di durare, è una realtà semplicemente "provvisoria", è una realtà che possiamo aprire ad orizzonti impensabilmente più luminosi, a patto di fare profondamente nostra "la convinzione che non è necessario che il dolore esista"...
Conversazione con Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia
Amnesty International, a metà di agosto, con un suo dettagliatissimo rapporto (intitolato Nessun luogo è sicuro per i civili: attacchi dal cielo e da terra nello Yemen), ha accusato le forze della coalizione a guida saudita e i gruppi armati favorevoli e contrari agli houti di aver ucciso centinaia di civili, tra cui decine di bambini, in azioni militari a Ta'iz e Aden equivalenti a crimini di guerra.*
Nel rapporto si illustrano le rovinose conseguenze dei bombardamenti contro zone residenziali densamente abitate e degli attacchi da terra, indiscriminati e sproporzionati, compiuti dalle forze pro-houti e da quelle anti-houti, evidenziando una strategia di bombardamenti su aree densamente popolate, nei pressi delle quali, nella maggior parte dei casi, non è stato possibile rinvenire alcun obiettivo militare.
"Le forze della coalizione - ha affermato Donatella Rovera, alta consulente per le crisi di Amnesty International - sono del tutto venute meno all'obbligo, previsto dal diritto internazionale umanitario, di prendere le misure necessarie per ridurre al minimo le perdite civili. Gli attacchi indiscriminati che provocano morti e feriti tra i civili costituiscono crimini di guerra".
A fine ottobre, poi, Amnesty International Italia, unitamente alla Rete Italiana per il Disarmo e all'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e Politiche di Difesa e Sicurezza (OPAL) di Brescia, ha fatto richiesta al Governo italiano di sospendere l'invio di bombe e armamenti a tutti i paesi militarmente impegnati nel conflitto in Yemen, dichiarando inaccettabile che, mentre l'Unione Europea attua la scelta di assegnare il Premio Sakharov al blogger saudita incarcerato Raif Badawi (condannato a subire 1.000 frustate), dall'Italia siano partite nuove bombe destinate all'Arabia Saudita, principale responsabile dei bombardamenti che - senza alcun mandato internazionale - da sette mesi stanno causando migliaia di morti (e indicibili sofferenze) tra i civili della popolazione yemenita.
In questi ultimi giorni, poi, a seguito delle sconcertanti dichiarazioni del Ministro della Difesa, Roberta Pinotti, secondo cui le forniture italiane di bombe aeree all'Arabia Saudita sarebbero "regolari" e "nel rispetto della legge", le suddette organizzazioni hanno fatto richiesta di un incontro urgente con il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, per chiarire la posizione del Governo italiano sulle esportazioni di armamenti.
A Riccardo Noury, portavoce ufficiale di Amnesty Italia, abbiamo chiesto di provare a fare il punto della questione.
- Quali richieste sono state avanzate al Governo italiano e che tipo di risposte, al momento, sono state rilasciate?
- Abbiamo chiesto, ormai diverse volte negli ultimi mesi, al governo di sospendere ogni trasferimento di armi verso l'Arabia Saudita. Al momento queste richieste non risultano accolte e, rispetto al silenzio imbarazzato delle scorse settimane, ora il governo - attraverso il ministro della Difesa - rivendica la legittimità dell'invio di bombe  alle forze armate saudite.
alle forze armate saudite.
- Quanto incide la nostra fornitura militare sull’apparato bellico dell’Arabia Saudita? E quali sono gli altri grandi fornitori internazionali?
- Ha la sua parte rilevante, anche se i principali fornitori sono gli Usa, che hanno trasferito armi per un valore di 1 miliardo e 300 milioni di dollari. Per quanto riguarda l'Italia, solo l'azienda coinvolta nei recenti invii, la RWM, ha spedito negli ultimi tre anni forniture all'Arabia Saudita per oltre 60 milioni di euro.
- La condizione dei diritti umani, in Arabia Saudita, stando a quanto si evince dal Rapporto 2014-2015 ** di Amnesty International, appare tutt’altro che felice. Si parla, infatti, di discriminazioni sessuali e religiose, di arresti e detenzioni arbitrari, di torture, maltrattamenti, di numerose condanne a morte. In esso leggiamo, tra l’altro, che
“Il governo ha imposto rigide restrizioni alle libertà d’espressione, associazione e riunione e ha represso duramente il dissenso, arrestando e incarcerando persone che lo avevano criticato, compresi difensori dei diritti umani. Molti hanno affrontato procedimenti giudiziari iniqui, celebrati da tribunali che non hanno rispettato le procedure dovute”, equiparando al terrorismo le critiche nei confronti del governo e altre attività del tutto pacifiche.
Certamente, il caso di Raif Badawi*** ha goduto, a livello mediatico, di una qualche visibilità. Quante situazioni analoghe, assai meno note, sono state recentemente registrate?
- Di prigionieri di coscienza, condannati per reati di opinione, ne contiamo almeno 10, tra cui lo stesso avvocato di Raif. I principali fondatori e dirigenti della più importante organizzazione per i diritti umani, l'Associazione saudita per i diritti civili e politici, stanno scontando pesanti condanne. Ci sono poi i casi dei due al-Nimr, zio e nipote, sceicco il primo, attivista il secondo della minoranza religiosa sciita, entrambi condannati a morte. Da ultimo, c'è il caso di un poeta palestinese condannato a morte a metà novembre per aver messo in dubbio l'esistenza di Dio ...
- In questi ultimi anni, le ricerche condotte da Amnesty International sono state in grado di constatare qualche significativo miglioramento della salute dei diritti umani in Arabia Saudita?
- Al contrario, abbiamo assistito a un peggioramento. Le leggi antiterrorismo emanate di recente hanno prodotto già i primi danni, con arresti arbitrari e processi irregolari. Il numero delle condanne a morte eseguite fin qui nel 2015 è arrivato a 150, un record negativo. C'è poi sempre la questione della discriminazione nei confronti delle donne, cui, come è noto, è impedito di guidare da sole e di prendere importanti decisioni sulla loro vita (sposarsi, viaggiare all'estero, intraprendere una carriera universitaria o professionale, persino sottoporsi ad alcuni interventi chirurgici) senza l'autorizzazione di un "tutore", di solito un parente maschio.
- Molti commentatori e opinionisti, in questi ultimi giorni, indicano spesso l’Arabia Saudita fra i massimi finanziatori dell’Isis: ipotesi azzardate o degne di essere prese in considerazione?
- Si è molto speculato su questa ipotesi. Che l'Isis abbia ricevuto almeno inizialmente sostegno dalle monarchie sunnite del Golfo, Arabia Saudita inclusa, è indubbio. Fondazioni private (che però in paesi del genere possono operare solo col consenso o con l'autorizzazione dei governi), in Arabia Saudita e in Kuwait, hanno finanziato l'Isis. Addirittura uomini delle forze di sicurezza del Bahrein sono stati scoperti tra le fila del gruppo armato. A un certo punto, gli obiettivi delle monarchie sunnite e dell'Isis non sono più coincisi e l'Isis, da strumento da armare per rovesciare il presidente siriano Assad, è diventato una minaccia per i regimi dell'area. Ufficialmente, il flusso di aiuti e armi è terminato. Sottolineo l'avverbio ufficialmente...
*http://www.amnesty.it/Bombe-italiane-ad-Arabia-Saudita-inaccettabile-che-per-ministro-Pinotti-sia-tutto-regolare
**http://rapportoannuale.amnesty.it/2014-2015
***https://appelli.amnesty.it/raif-badawi/
Nel testo dell’Enciclica Laudato sì, una importanza del tutto particolare è accordata al concetto di interdipendenza. Papa Francesco, infatti, attingendo al Catechismo, afferma che è proprio Dio a volere che, fra le sue creature, ci sia questo strettissimo e indissolubile legame.
“Il sole e la luna, il cedro e il piccolo fiore, l’aquila e il passero: le innumerevoli diversità e disuguaglianze  stanno a significare che nessuna creatura basta a se stessa, che esse esistono solo in dipendenza le une dalle altre, per completarsi vicendevolmente, al servizio le une delle altre”. (Papa Francesco, Laudato sì, Capitolo secondo, IV, 86)
stanno a significare che nessuna creatura basta a se stessa, che esse esistono solo in dipendenza le une dalle altre, per completarsi vicendevolmente, al servizio le une delle altre”. (Papa Francesco, Laudato sì, Capitolo secondo, IV, 86)
Ora, papa Francesco, dopo aver puntualizzato che simili concetti non dovrebbero, però, autorizzarci ad “equiparare tutti gli esseri viventi” (ivi, Capitolo secondo, IV, 90), togliendo all’essere umano quel “valore peculiare che implica allo stesso tempo una tremenda responsabilità”, né comportare una sorta di “divinizzazione della terra” (evidentemente ritenuta pericolosamente filo-pagana), dichiara assolutamente inautentico (e come tale inaccettabile) “un sentimento di intima unione con gli altri esseri della natura” che non implichi anche “tenerezza, compassione e preoccupazione per gli esseri umani.” (ivi, Capitolo secondo, IV, 91)
Ma la cosa veramente rivoluzionaria è che tale asserzione venga poco più avanti capovolta, in modo tale da poter affermare che
“è vero anche che l’indifferenza o la crudeltà verso le altre creature di questo mondo finiscono sempre per trasferirsi in qualche modo al trattamento che riserviamo agli altri esseri umani. Il cuore è uno solo e la stessa miseria che porta a maltrattare un animale non tarda a manifestarsi nella relazione con le altre persone.” (ibidem)
Aggiungendo, subito dopo, che ogni forma di maltrattamento nei confronti di ogni creatura debba essere considerata contraria alla “dignità umana” e, quindi, come tale, impossibile da ritenersi moralmente irrilevante o semplicemente tollerabile.
E’ impossibile, infatti, secondo papa Bergoglio, che ci si possa stimare persone “che amano veramente” quando si verrebbe ad escludere dai propri interessi “una parte della realtà”.
A questo proposito, I.Kant, in una delle sue Lezioni di etica, più di due secoli fa, sosteneva che
“ l’uomo deve mostrare bontà di cuore già verso gli animali, perché chi usa essere crudele verso di essi è altrettanto insensibile verso gli uomini. Si può conoscere il cuore d’un uomo già dal modo in cui egli tratta le bestie.” (I.Kant, Lezioni di etica, Laterza, Bari 1971, p.273)
“Tutto è in relazione - scrive Francesco in interessantissimo accordo con il principio dell’unità della vita, pilastro fondativo e costitutivo del pensiero ermetico-teosofico - e tutti noi esseri umani siamo uniti come fratelli e sorelle in un meraviglioso pellegrinaggio, legati dall’amore che Dio ha per ciascuna delle sue creature e che ci unisce anche tra noi, con tenero affetto, al fratello sole, alla sorella luna, al fratello fiume e alla madre terra.” (op.cit., Capitolo secondo, IV, 91)
Citando poi un testo episcopale del 1987, il pontefice sottolinea che “Pace, giustizia e salvaguardia del creato sono tre questioni del tutto connesse” e che, pertanto, mai andrebbero affrontate separatamente. Principio questo abbracciato e insistentemente difeso da tutti i grandi maestri della nonviolenza, da Tolstoj a Schweitzer e a Gandhi. Aldo Capitini, in particolare, in sintonia con le grandi esperienze filosofico-religiose del passato (dal jainismo al pitagorismo e al buddhismo), decise di operare la scelta vegetariana come atto politico-pedagogico di rivolta nei confronti della dittatura fascista e della sua barbarica (in)cultura, ritenendo che il diffondersi del rifiuto dell’esercizio della violenza nei confronti degli animali avrebbe reso meno facilmente accettabile la pratica della violenza nei confronti degli stessi uomini.
 |
| Il prof.Aldo Capitini |
“ Il vegetarianesimo - afferma infatti Capitini - è il rivolgersi a un gruppo di esseri non umani prendendo l’iniziativa di stabilire un rapporto di apertura, e non più di indifferenza o di crudeltà. E questo allargamento fa sì che sia a maggior ragione difficile l’indifferenza o la crudeltà verso gli uomini. Confesso che io diventai vegetariano proprio sotto il regime della violenza fascista che preparava la guerra, perché pensavo che se si imparava a risparmiare l’uccisione di animali, con maggior ragione si sarebbe risparmiata l’uccisione di uomini.” (Aldo Capitini, L’educazione è aperta. Antologia degli scritti pedagogici, Levante editori, Bari 2008, p.210)
E’ stato proprio nell’ottica (tanto cara a papa Francesco) dell’indissolubile carattere di interdipendenza di tutto ciò che vive, che Capitini, come tanti altri grandi personaggi prima di lui (dal Buddha a Leonardo da Vinci, da Mazzini ad Einstein), approdò con rigore logico alla scelta di ridurre il più possibile qualsiasi forma di
violenza nei confronti di ogni essere, ritenendo il rifiuto del carnivorismo un atto dovuto e ineludibile in vista della promozione di un mondo sempre più liberato dall’ingiustizia e dal dolore.
“Oltremodo drammatica è la realtà di tutti - scrive il filosofo perugino - perché ravvisa in noi il senso dell’insufficienza di uno stato di cui quasi ci accontenteremmo ottusi, e ci riaccende la protesta contro l’umanità-società-realtà attuale, e il dolore per ogni essere che vediamo soffrire, anche il gatto morente che ho
visto questa mattina nell’angolo di una strada che ha alzato lo sguardo dei suoi occhi celesti e ancora brillanti verso me che lo chiamavo; ma nel farci vivere profondo il dramma, ci radica il senso della liberazione, dell’autenticità della realtà in cui tutti gli esseri sono presenti.” (ivi, p.75)
Arriverà anche questo papa (come già anche non pochi cristiani prima di lui) ad operare una simile scelta, anche al fine di un utilizzo necessariamente più equo e razionale delle risorse del pianeta (assorbite in maniera abnorme dalla zootecnia) nonché di una significativa diminuzione delle forme attuali di inquinamento?
Credo che, sulla base delle rivoluzioni culturali in atto all’interno della visione cattolica della realtà, abbracciare il vegetarianesimo, con possibile ulteriore apertura verso il veganismo, dovrebbe essere considerato come un elementare gesto di coerente concretezza.
Che senso avrebbe, infatti, limitarsi a parlare dei “legami invisibili” che fanno di tutte le creature “una sorta di famiglia universale, una comunione sublime che ci spinge ad un rispetto sacro, amorevole e umile” (op.cit., Capitolo secondo, IV, 89) e poi continuare (tra agnelli pasquali e tacchini natalizi) a tollerare e a causare le infinite forme di sofferenza atroce a cui miliardi di creature senzienti sono sottoposte per consentirci di riempire la nostra tavola e il nostro stomaco con ciò che resta dei loro corpi ben poco fraternamente macellati?
Triste davvero sarebbe il trovarci costretti a constatare, ancora una volta, dopo pur tanti luminosi progressi, il perdurare nella Chiesa cattolica della ben collaudata strategia della contraddittorietà fra le cose “predicate” e quelle “razzolate” …
In altre parole, se il papa crede davvero in ciò che scrive e predica, ovverosia che “lo stile di vita attuale, essendo insostenibile, può sfociare solamente in catastrofi” (ivi, Capitolo Quarto, III, 161), e che, pertanto, tutti noi (e i cristiani in prima linea) siamo invitati a praticare una conversione da lui definita “ecologica”, sforzandoci, cioè, di farci custodi virtuosi del mondo e non più suoi brutali tiranni, prendendo tra l’altro a modello Francesco d’Assisi, e instaurando così “una sana relazione col creato come una dimensione della conversione integrale della persona” (ivi, Capitolo Sesto, III, 218), come non procedere poi, conseguentemente, alla promozione e all’adozione di una alimentazione fondata sulla massima eliminazione possibile dello sfruttamento, della schiavizzazione, della reificazione, del massacro di miliardi di esseri viventi, fragili membri di quella “famiglia universale” in cui dovremmo vivere in uno stato di “comunione sublime”?
In definitiva, come conciliare “l’amorevole consapevolezza di non essere separati dalle altre creature, ma di formare con gli altri esseri dell’universo una stupenda comunione universale” (ivi, Capitolo Sesto, III, 220) con il continuare ad opprimere e sterminare masse incalcolabili di animali?
Papa Francesco si riferisce anche a Gesù che, nel Vangelo di Luca (12,6) parla degli uccelli, affermando che ognuno di loro è destinatario dell’attenzione paterna di Dio, chiedendosi se “saremo capaci di maltrattarli e far loro del male” e invitando, di conseguenza,
“tutti i cristiani a esplicitare questa dimensione della propria conversione, permettendo che la forza e la luce della grazia ricevuta si estendano anche alla relazione con le altre creature e con il mondo che li circonda, e susciti quella sublime fratellanza con tutto il creato che san Francesco d’Assisi visse in maniera così luminosa.” (ivi, Capitolo Sesto, III, 221 )
Ecco quindi il problema che papa Bergoglio pone e che, d’ora in avanti, i cattolici che vorranno proseguire il loro pellegrinaggio in sua compagnia non potranno più facilmente eludere:
come conciliare l’aspirazione ad una vita di “sublime fratellanza” con l’intero creato continuando a mangiare spensieratamente le carni dei propri fratelli (meno intellettualmente dotati e più fragili di noi umani)?!
Gran festa ieri a Roma , l’arte ha voluto rendere omaggio a coloro che si prodigano per il bene del prossimo. Organizzato dalla Free Lance International Press, associazione di giornalisti freelance a carattere internazionale, con la collaborazione di Amnesty International Italia, Cittanet e lo studio Scopelliti-Ugolini , si è svolto presso l’aula magna della facoltà di teologia valdese il “Premio Italia Diritti Umani 2015” per commemorare la tragica scomparsa dell’ ex Vice-presidente dell’associazione Antonio Russo, ucciso nel 2000’ mentre indagava sulla tragedia cecena. Di grandissimo spessore le persone premiate: Riccardo Rossi, Silvia Cutrera e Massimo de Angelis. Una menzione speciale per i diritti umani è andata alla poetessa Anna Manna.
Prima della premiazione ci sono stati gli interventi di Yilmaz Orkan - Membro Congresso Nazionale Kurdistan KNK (il problema curdo in Siria e in Turchia), Antimo della Valle - Giornalista e saggista, direttore di Editorpress (L'informazione che cambia nell’epoca dei digital media), Vittorio Badalone – col. cap. uff. operazioni di addestramento Isp. Naz. corpo militare della CRI (Gli interventi umanitari del corpo militare della CRI), Riccardo Noury - Portavoce di Amnesty International sezione Italia (La crisi dei rifugiati e l'egoismo dell'Europa), Antonio Cilli: Cittanet founder (Il nuovo ruolo del giornalismo locale), Roberto Zaccaria - Presidente del Cir – Consiglio Italiano per i Rifugiati (Il ruolo dei media nel comunicare le migrazioni), Andrea D’Emilio ed Erica Greco (Antonio Russo a “Rivoluzioniamo Rancitelli”: il suo ritratto nel ghetto della Rivoluzione, a Pescara.)
Queste le motivazioni dei tre premi:
A Riccardo Rossi
 “Si conferisce il premio Italia diritti umani 2015
“Si conferisce il premio Italia diritti umani 2015
A RICCARDO ROSSI.
Riccardo Rossi, il giornalista chiamato il “mastino napoletano”, addetto stampa di politici noti, frequentava deputati e personaggi illustri e scriveva per loro ciò che loro pretendevano che venisse scritto andando anche contro la verità contingente.
La scoperta di avere un fratello soggiogato alla droga, esasperato dalle pressioni di linee editoriali legate a giri di malaffare ed il ricordo di un bambino di strada incontrato in Romania, lo convinsero a dedicarsi totalmente agli altri, ai diritti umani innanzitutto.
Riccardo Rossi ha scelto di vivere presso la Casa Famiglia “Oasi della Divina Provvidenza” a Pedara (CT), antico borgo alle falde dell’Etna, in Sicilia.
Oggi Riccardo aiuta i disabili e i malati terminali. Scrive notizie e articoli ma solo quelle belle, positive, quelle notizie che ad ascoltarle danno gioia e felicità oltre ad infondere tranquillità profonda. “La Gioia” è un giornale di buone notizie che vuole ispirare gesti solidali. Nasce come braccio operativo dell’Associazione “La Gioia onlus” che vuole, tramite la comunicazione, ispirare percorsi di carità.”
A Silvia Cutrera
“Si conferisce il premio Italia diritti umani 2015
a Silvia Cutrera, Presidente dal 2006 dell'Associazione di persone con disabilità, Agenzia per la Vita Indipendente onlus di Roma, per il suo impegno caparbio, assiduo e coraggioso per l'affermazione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, sempre sostenuto da raffinata sensibilità e da lucida intelligenza.
L'associazione Agenzia per la Vita Indipendente Onlus costituitasi nel settembre 2002, promuove e sostiene la realizzazione di programmi personali di assistenza autogestita di persone con disabilità, organizza eventi in occasione dei quali viene sensibilizzata l'opinione pubblica in relazione al tema della Vita indipendente e dell'inclusione sociale, presenta proposte per la realizzazione di servizi di affiancamento delle persone con d isabilità, promuove iniziative culturali per lo sviluppo della conoscenza dell' Aktion T4 rispetto agli eventi di segregazione e sterminio nei confronti delle persone disabili durante il nazismo, organizza eventi e premi per la promozione culturale della visione positiva della persona con disabilità.
isabilità, promuove iniziative culturali per lo sviluppo della conoscenza dell' Aktion T4 rispetto agli eventi di segregazione e sterminio nei confronti delle persone disabili durante il nazismo, organizza eventi e premi per la promozione culturale della visione positiva della persona con disabilità.
Attualmente offre servizi a circa 500 associati, a cui è stato possibile garantire una migliore accoglienza, ascolto e affiancamento.
In questi anni l'associazione è diventata un punto di riferimento per le persone con disabilità che scelgono la forma di assistenza indiretta, anche per il continuo dialogo che l'associazione ha instaurato con molti municipi, offrendo anche servizi a persone provenienti da altri comuni.
L'Agenzia per la Vita Indipendente Onlus provvede direttamente a realizzare i progetti, privilegiando l'impiego volontario (e in prospettiva lavorativo) di persone con disabilità, caratterizzando la sua attività come servizi offerti da persone disabili in favore di persone disabili, al fine di promuovere il loro impegno attivo , in quanto soggetti attivi e non solo fruitori dei servizi. “
A Massimo de Angelis
“Dopo aver lavorato per quasi 20 anni nella carta stampata, occupandosi tra l’altro di scuola, ambiente e anni di piombo, Massimo de Angelis ha ricoperto per altri 20 anni l’incarico di inviato speciale in Rai, quasi esclusivamente al Tg1.
Oltre ai più gravi fatti di terrorismo e di mafia e a eventi tragici (terremoti, DC9 di Ustica, tsunami), ha testimoniato dal campo i principali conflitti internazionali degli ultimi  anni: Somalia, Bosnia, Albania, Sierra Leone, Kossovo, Libano, Sud Sudan, Afghanistan.
anni: Somalia, Bosnia, Albania, Sierra Leone, Kossovo, Libano, Sud Sudan, Afghanistan.
Sul tema dei diritti dell’infanzia ha realizzato inchieste e “speciali” sullo sfruttamento dei bambini in India, in Congo e in Guatemala.
Da freelance ha realizzato per conto di organizzazioni di volontariato documenti filmati su numerosi temi tra cui i bambini in carcere, la maternità minorile e la sclerosi multipla. Ha inoltre collaborato con Cesvi, Save the Children, Coopi realizzando fra l’altro reportage filmati in Uganda, Tagikistan, Haiti e Niger.
Dal 2013, Massimo de Angelis ha messo la sua professionalità ed esperienza a disposizione di Amnesty International, realizzando con estrema sensibilità e competenza in materia di diritti umani due documenti filmati, rispettivamente sulla violenza contro le donne e sul 40° anniversario di Amnesty International Italia.
Questi documenti filmati, trasmessi dalla Rai, hanno dato un grande contributo alla conoscenza di Amnesty International che, per questo, è fortemente riconoscente a Massimo de Angelis e ha deciso di ringraziarlo attraverso questo premio della Free Lance International Press per i diritti umani del 2015.”
Per la poetessa Anna Manna di seguito la motivazione della menzione speciale:
”La poesia di Anna Manna è un essere dentro il mondo, ma insieme è creare un altro mondo dove amore e comprensione trovano compimento. Poetessa e scrittrice dai molti riconoscimenti nazionali ed internazionali, è qui premiata soprattutto per le sue liriche che ritraggono il dramma dei migranti e della loro disperata fuga verso un futuro migliore troppo spesso perito in mare.
La poesia che è particolarmente menzionata invoca nella Vergine una icona quasi archetipica di protezione e misericordia, un femminile universale cui tutti, cattolici e non , possono guardare nella speranza di costruire un avvenire a dimensione più umana.
O è forse la poesia di Anna che esorcizza il male e ci aiuta a riscoprire, pur tra le tragedie, una luce in fondo al tunnel?
Per le sue liriche e per l’importante azione in favore della poesia come promozione umana e civile, si conferisce ad Anna Manna la Menzione speciale del Premio Italia  Diritti Umani 2015.”
Diritti Umani 2015.”
Hanno consegnato i premi:
l’attrice Chiara Pavoni, di origini marchigiane, da anni impegnata nel sociale, la quale ha lavorato con i maggiori registi del mondo dello spettacolo e della performance. Da oltre un anno è in scena con un monologo contro la violenza sulle donne “Tragicamente rosso”, scritto da Michela Zanarella. Suo è stato l’applauditissimo monologo al Premio Italia Diritti Umani 2005: "Il mio nome è freelance", scritto sempre da Michela Zanarella e diretto da Giuseppe Lorin.
La scultrice Alba Gonzales. E’ conosciuta come la sintesi dell'eredità michelangiolesca commista all’eredità araba, normanna, etrusca e celtica. Le sue opere scultoree racchiudono il concetto di archetipo femminile, ovvero l’eterno femminino riferito al
| L'attrice Chiara Pavoni |
Rinascimento perché è anche con lo scalpello e la fusione del bronzo che si scrive la
storia dell’umanità.
A Fregene, ha fondato nel suo spazio, il Museo di scultura all'aperto “Pianeta Azzurro”, con il Centro Internazionale di Scultura Contemporanea. In occasione dell’evento “L’Isola del Cinema”, alcune sue opere in bronzo sono state esposte sulla riva destra del Tevere.
Vittorio Pavoncello, romano, regista, drammaturgo, artista nelle arti visive, fondatore del teatro ebraico Kavvana e dell'ArteEcò (arte ed ecologia) è regista, autore, poeta e attore.È un uomo di cultura. Sue opere sono esposte nei maggiori musei del mondo. Tra queste si ricordano "La lampada della Pace", scultura per il Santuario Francescano di Greccio (Rieti) per l'Appello di Pace al mondo UNICEF, e "Le città invisibili" in omaggio a Italo Calvino. È l’ideatore dell’illuminazione dell’Anfiteatro Flavio, il Colosseo, per i Diritti Umani al Senato di Roma ha presentato “La mia storia ti appartiene, persone con disabilità si raccontano”.
Sono state donate opere degli artisti:
Federico Gismondi: scultore, pittore, incisore, medaglista, poeta, scrittore, operatore culturale, nasce a Ridotti, Balsorano (Aq.) nel 1936, vive abitualmente ad Alatri (Fr).
Le sue opere sono collocate in collezioni e importanti musei regionali, nazionale ed esteri, tra cui: Citta del Vaticano. Museo di Arte Moderna di Citta del Messico- Museo di Arte Moderna di Baghdad - Museo di Arte Contemporanea Italiana di Durazzo - Gabinetto delle Stampe di Reggio Emilia- "Stauros"Museo lnternazionale di Arte Sacra,IsoIa del Gran Sasso(TE)- "Controguerra"Museo lnternazionale Mai|Art della Citta di L'Aquila- Fondazione U.Mastroianni di Arpino- Museo del Presepe degli Artisti Contemporanei di L'Aquila - "Un Arcobaleno di Angeli" MailArt lnternazionale, S.Giuliano di Pug|ia (CB) - Fondazione E.Mattei, Civitella Roveto (Aq.) - Collezione Giorgio Mondadori, Milano - Collezione Ada Zunino, Milano.
Nell’intermezzo, tra gli interventi e la premiazione, per gli ospiti è stato preparato in ricco buffet gentilmente offerto dal Ristorante “Al 59”di Roma e dall’azienda agricola Castel De Paolis di Grottaferrata.

“Premio Italia diritti umani 2015” ®
Dedicata alla memoria dell’ ex Vice-presidente della Free Lance International Press Antonio Russo.
Aula Magna della facoltà valdese di teologia
Via Pietro Cossa 40 (piazza Cavour) ROMA
Roma 15 Ottobre 2015
Il Premio Italia Diritti Umani nasce dall’esigenza da parte delle associazioni coinvolte di voler dare un giusto riconoscimento a coloro che, per la loro attività, si sono distinti nel campo dei diritti umani. In un mondo in cui il profitto sembra essere lo scopo ultimo di ogni intento, bisogna sostenere chi lotta veramente, sacrificando spesso gran parte (o del tutto) la propria esistenza per aiutare il prossimo. I Mass Media spesso non prestano la dovuta attenzione al tema dei diritti umani, se non in maniera superficiale. È giunto quindi il momento, non solo di dare un giusto riconoscimento a chi lotta per la difesa dei più deboli, ma anche di parlare su come possano essere tutelati meglio questi diritti che, anche in paesi come l’Italia oltre che all’estero, sono sistematicamente violati, soprattutto nei confronti dei più deboli.
In collaborazione con - Amnesty International – sezione italiana , Cittanet, Studio Scopelliti-Ugolini
 |
 |
 |
PROGRAMMA
Moderatrice e presentatrice del premio: Neria De Giovanni, giornalista, Presidente dell’Associazione Internazionale dei Critici Letterari.
Interventi
Ore 16.00 - Saluti
Virgilio Violo – giornalista- Presidente della Free Lance International Press
Ore 16.05 - il problema curdo in Siria e in Turchia
Yilmaz Orkan - Membro Congresso Nazionale Kurdistan KNK
Ore 16.15 – L’informazione che cambia nell’epoca dei digital media
Antimo della Valle - Giornalista e saggista, direttore di Editorpress
Ore 16.30 – Gli interventi umanitari del corpo militare della CRI
Vittorio Badalone – col. cap. uff. operazioni di addestramento Isp. Naz. corpo militare della CRI
Ore 16.45 - "La crisi dei rifugiati e l'egoismo dell'Europa"
Riccardo Noury - Portavoce di Amnesty International sezione Italia
Ore 17.00 – l’esperienza di un’insegnante alla città dei ragazzi.
Maria Foffo - professoressa di italiano e pedagogista
Ore 17.15– Il nuovo ruolo del giornalismo locale
Antonio Cilli: Cittanet founder
Ore 17.15 - Il ruolo dei media nel comunicare le migrazioni.
Roberto Zaccaria - Presidente del Cir – Consiglio Italiano per i Rifugiati
Ore 17.30 - Antonio Russo a “Rivoluzioniamo Rancitelli”: il suo ritratto nel ghetto della Rivoluzione (a Pescara)
Andrea D’Emilio ed Erica Greco
_________________________________
Ore 17.40 Monologo: "Il mio nome è freelance"
scritto da Michela Zanarella, diretto da Giuseppe Lorin, interpretato da Chiara Pavoni.
PREMIAZIONE ore 18,00
Menzione speciale per i diritti umani
Legge la motivazione Giuseppe Lorin
- Consegnano i premi e leggono le motivazionii:
Chiara Pavoni attrice, Alba Gonzales scultrice e Vittorio Pavoncello regista.
Donate opere degli artisti: Federico Gismondi, Patrizia Borrelli, Anna San
FREE LANCE INTERNATIONAL PRESS
via Federico Cesi 44 - 00193 Roma, Italy
-t. /fax 0039 06-96039188
sito web www.flipnews.org e mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Afghanistan: ospedale di Medici Senza Frontiere* distrutto da bombe americane
di Roberto Fantini
Ogni tanto, ma sempre più di rado, ci ritroviamo a parlare di Afghanistan…
Ma come, i feroci talebani, colpevoli di tutti i mali del mondo, non erano stati sbaragliati e dispersi, già qualche mese dopo la tragedia delle Torri gemelle? Non ci avevano forse raccontato le galvanizzate frotte di pennivendoli nazionali che i liberatori avevano stravinto, portando trionfalmente la “civiltà” in quelle terre selvagge, fra un taglio di barba e un festante falò di burqa colorati?!
Ma chi sa qualcosa della storia di questo malandato nostro mondo sa benissimo che la prima vittima di tutte le 
Quello che un po’ tutti ci siamo dimenticati è che, da quasi 15 anni, nel paese più povero e sfortunato del globo, si prosegue una guerra concepita e partorita dalle menzogne e portata avanti nelle menzogne. E, a volte, capita che lo spesso velo mediaticomilitare dell’inganno si squarci e lasci apparire l’”orrido vero”. E’ il caso, in queste ultime ore, dell’ignobile bombardamento americano dell’ospedale di Medici Senza Frontiere a Kunduz, con l’inevitabile, incalcolabile bilancio di vite distrutte, di devastazione e di sofferenza.
La cosa più insopportabile e repellente, poi, in casi come questi, è sentir parlare di “incidente” o di “tragico errore”. Proprio come ha subito provveduto a fare l’efficientissimo colonnelloBrian Tribus, portavoce delle forze Usa in Afghanistan, con la seguente vergognosa dichiarazione:
"Le forze americane hanno condotto un attacco aereo nella città di Kunduz alle 2.15 (ora locale) contro individui che minacciano le forze. L'attacco potrebbe avere provocato danni collaterali a una struttura medica vicina".
In un comunicato di qualche giorno prima (29 settembre), Medici Senza Frontiere rivelava che l’ospedale di Kunduz, in seguito ai pesanti combattimenti tra forze governative e dell’opposizione, era stracolmo di feriti (tra cui molti bambini) e che la struttura (capace di effettuare nell’intera giornata di lunedì della passata settimana ben 43 interventi chirurgici) era al limite e in grandi difficoltà nel gestire il continuo crescente afflusso di feriti.
Il comunicato si concludeva assai opportunamente sottolineando:
- Che, essendo in questo momento l’ospedale provinciale del governo non in funzione, l’ospedale di MSF costituiva l’unica struttura a Kunduz in grado di fornire cure traumatologiche urgenti.
- Che i medici di MSF, come sempre, nel prendersi cura delle persone bisognose, non fanno alcuna distinzione in base a etnia, credo religioso o affiliazione politica.
- 
Nel comunicato del 3 ottobre, MSF ribadisce poi, con la necessaria fermezza,
“che tutte le parti in conflitto, comprese Kabul e Washington, erano perfettamente informate della posizione esatta delle strutture MSF - ospedale, foresteria, uffici e unità di stabilizzazione medica a Chardara (a nord-ovest di Kunduz)”, specificando chiaramente che, come in tutti i contesti bellici, era stata cura dell’organizzazione comunicare
“le coordinate GPS a tutte le parti del conflitto in diverse occasioni negli ultimi mesi, la più recente il 29 settembre”.
Inoltre, il comunicato evidenzia il fatto che
il bombardamento sia stato proseguito “per più di 30 minuti da quando gli ufficiali militari americani e afghani, a Kabul e Washington, ne sono stati informati”.
“Questo attacco è ripugnante ed è una grave violazione del Diritto Internazionale Umanitario” ha dichiarato Meinie Nicolai, presidente di MSF, attualmente in Italia.
“Chiediamo alle forze della Coalizione completa trasparenza. Non possiamo accettare che questa terribile perdita di vite umane venga liquidata semplicemente come un ‘effetto collaterale’.”
Aggiungendo poi che, oltre ad aver provocato la morte di personale medico e di pazienti,
“questo attacco ha privato la popolazione di Kunduz della possibilità di accedere alle cure nel momento in cui ne ha maggiormente bisogno”.
Al momento dell’attacco aereo nell’ospedale, c’erano 105 pazienti insieme alle persone che li accudivano, oltre a più di 80 operatori internazionali e nazionali di MSF.
Ora, dopo una ventina di morti e decine di feriti e dispersi, MSF si trova costretta ad abbandonare Kunduz …

L’associazione si è poi dichiarata molto preoccupata per il costante peggioramento delle condizioni di sicurezza, affermando che la violenza e l'instabilità in cui l'Afghanistan sta precipitando rendono sempre più difficile garantire l'attività degli operatori umanitari, aggravando ulteriormente le condizioni della popolazione.
Vittorio Zucconi, in un suo articolo di domenica 4 ottobre, scrive che l'attacco aereo all'ospedale di Kunduz
“ha il sapore disperante, eppure prevedibile, del " deja vu", della replica di tragedie già viste” e che “la cronistoria della spedizione punitiva contro il regime che aveva accolto e protetto i comandi di Al Quaeda negli anni '90 è punteggiata di episodi come questo dell'ospedale di Kunduz, prodotti non della crudeltà, della stupidità militare, della stoltezza di bombe che non possono mai essere più " intelligenti" di chi le lancia, ma figli dell'inevitabile degenerazione di guerre che dopo l'illusione iniziale della " missione compiuta" si trasformano in interminabili e controproducenti " missioni incompiute".
No, caro Zucconi, questi orribili eventi non sono figli di nessuna “inevitabile degenerazione”, sono bensì il coerente e ricercato effetto di questa guerra e i responsabili hanno volti e nomi umani, quelli di coloro che questa guerra l’hanno accuratamente progettata, l’hanno prepotentemente promossa, l’hanno dichiarata (e fatta dichiarare) necessaria e giusta. Sono anche tutti coloro che, nei parlamenti come nelle redazioni dei giornali, questa guerra continuano (dal lontano settembre 2001) a sostenere e a benedire. Sono tutti coloro, cioè, che, in nome di rabberciate “vulgate”, di aprioristici feticci ideologici e di indicibili interessi, continuano a dimenticare quello che il grande Erasmo (cinque secoli fa) si sforzava di ricordarci:
che chi vuole la guerra “non l’ha vista in faccia” e che, soprattutto, non vuole che tutti noi la vediamo per quello che effettivamente rappresenta, ovvero la più grande e criminale delle violazioni dei diritti umani …
* Le attività di Medici Senza Frontiere nel Paese:
MSF ha iniziato a lavorare in Afghanistan nel 1980. A Kunduz, come nel resto del paese, operatori nazionali e internazionali lavorano insieme per garantire la migliore qualità dei trattamenti. MSF supporta il Ministero della Salute nell’ospedale Ahmad Shah Baba, nella zona orientale di Kabul, la maternità Dasht-e-Barchi nell’area occidentale di Kabul e al Boost Hospital a Lashkar Gah, provincia di Helmand. A Khost, in Afghanistan orientale, MSF gestisce un ospedale specializzato in maternità. MSF lavora in Afghanistan esclusivamente grazie a fondi privati e non accetta finanziamenti da nessun governo.
www.medicisenzafrontiere.it
Si può cercare di rendere migliore il mondo anche regalando un sorriso ai bambini meno fortunati
di Roberto Fantini
Oramai sono in tanti a conoscerlo e ad amarlo come il ragazzo che gira il mondo per giocare con i bambini degli orfanotrofi e i ragazzi di strada.
Ha venticinque anni, studi di cooperazione internazionale alle spalle e già migliaia e migliaia di chilometri nelle gambe, percorsi in decine e decine di paesi, per portare un sorriso ai bambini che ne hanno un abissale bisogno.
Durante i pochi giorni di una breve pausa estiva nella sua Sicilia, siamo riusciti a strappargli l’intervista che segue. Ora è già lontanissimo,  a Soddo, a duemila metri di altitudine, ad 8 ore dalla capitale etiopica, con l’intento di girare per tutta l’Africa.
a Soddo, a duemila metri di altitudine, ad 8 ore dalla capitale etiopica, con l’intento di girare per tutta l’Africa.
Poi, quando questa nuova esperienza sarà stata portata a termine, ha già in mente la splendida idea di fare un nuovo giro del mondo in carrozzina, per richiamare l’attenzione sul problema delle difficili ed ingiuste condizioni di vita dei disabili.
- Andrea, il tuo pellegrinaggio planetario, alla ricerca dell’infanzia colpita da sofferenze di ogni tipo, è certamente qualcosa di molto bello. Quando e come è nato in te questo desiderio? E quali sono gli obiettivi che ti prefiggi?
- Non smetterò mai di ringraziare l'esperienza, la mia esperienza. Già da ragazzo avevo fatto dei progetti solidali in Europa e, a soli 19 anni, mi sono ritrovato a fare attività in un orfanotrofio in Sudafrica. Ho scoperto la semplicità della gioia. Ho vari obiettivi, ma il principale è dimostrare come le culture sono diverse ma i bambini sono uguali in tutto il mondo e, per ringraziarli, vorrei fare costruire una piccola scuola o un ospedale primario in Africa.
- Che accoglienza hai trovato da parte delle istituzioni che gestiscono gli orfanotrofi? Gelosia, diffidenza, collaborazione, disponibilità?
- Le accoglienze che ho trovato sono state delle accoglienze che rispecchiavano i misteri delle istituzioni stesse. Dove le istituzioni avevano segreti da nascondere, si vedeva la diffidenza che si trasformava in paura. Dove le istituzioni erano più o meno oneste, di vedeva una diffidenza che si trasformava in collaborazione quando capivano i miei buoni e reali interessi.
- E dalle autorità governative dei vari paesi in cui ti sei mosso?
- Le accoglienze sono quasi sempre state di indifferente formalità nel mondo, l'unica nazione dov'è stato sempre difficilissimo entrare negli orfanotrofi è stata l’ India. Il governo è molto rigido, ho dovuto dichiarare al mio ingresso nel paese che ero lì per turismo e non per volontariato.
- Quali sono stati i momenti più difficili durante i tuoi viaggi?
- Il momento più difficile è stato, anzi è, trovare una risposta a questa domanda. Vivo di serenità e voglia di vivere. Forse i “no” di alcuni orfanotrofi, dopo chilometri di cammino, mi avevano un po' reso le giornate difficili, ma il riuscire ad entrare e giocare con nuovi amici ha avuto sapori molto più forti!
- Sei mai stato catturato dallo sconforto, arrivando a pensare di ritornartene a casa?
- La mia casa è il mondo, quindi ovunque sono stato mi sono trovato a mio agio. Sono arrivato a pensare, tutte le volte che sono stato male di salute, di passare da luoghi scomodi ad abitazioni di lusso, solo per vivere i malanni fra i lettoni e le infermiere! Ma, alla fine, la forza di alzarmi dai luoghi, scomodi accompagnato dai cori dei bambini fuori dalle mie porte, ha avuto sempre la meglio!
- E hai mai pensato, invece, che tutte le tue fatiche ben poco potranno cambiare la drammatica situazione di questo nostro povero mondo ammalato di odio? Che il destino dei bimbi con cui entri in contatto continuerà immutato il suo corso, presieduto da forze contingenti su cui non hai alcun potere?
- Ho la certezza che io non potrò cambiare l'odio sparso nel mondo, ma di sicuro ho due grandi e forti certezze. La prima è che le migliaia di bambini con i quali ho giocato scavalcano le mie fatiche e mi ricompensano ampiamente per essermi impegnato per  una giusta causa. La seconda certezza è che almeno un paio dei bambini, fra i tanti con cui ho giocato e fatto attività, andrà avanti, perché avrà come punto di riferimento un ragazzo bianco che ha saputo credere nel suo sogno di girare il mondo per provare a cambiare il futuro di tutti i bambini da lui incontrati.
una giusta causa. La seconda certezza è che almeno un paio dei bambini, fra i tanti con cui ho giocato e fatto attività, andrà avanti, perché avrà come punto di riferimento un ragazzo bianco che ha saputo credere nel suo sogno di girare il mondo per provare a cambiare il futuro di tutti i bambini da lui incontrati.
- Quali sono i tuoi progetti per il medio e per il lungo periodo?
- Finire di scrivere il mio libro, una miscela fra il diario di viaggio e le storie dei bambini, in cui, fra le tante cose, mi interrogo sulle cause che hanno prodotto e continuano a produrre tanti orfani. E, poi, mi piacerebbe presentare un format televisivo per diventare un presentatore di qualche programma educativo per i bambini … il presentatore allegro dall'accento siciliano! Mi piace!
Per contattare Andrea Caschetto:
www.facebook.com/andrea.caschetto.31
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
di Roberto Fantini
Papa Francesco, nella sua Enciclica Laudato sì, giustamente definita “unica” e “stupenda” da Leonardo Boff (Avvenire, 19 giugno), appellandosi all’autorevolezza dell’amatissima figura di Francesco d’Assisi, mette in luce in modo insistito come sia impossibile pretendere di costruire un futuro migliore “senza pensare alla crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi”. 1) E a tal fine rivolge a tutti noi, credenti e non, “un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta” 2), sottolineando la necessità di un confronto capace di coinvolgerci ed unirci in vista di una “nuova solidarietà universale”, superando tutti quegli “atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione”, ovvero: negazione del problema; indifferenza; comoda rassegnazione; fiducia cieca nelle soluzioni che potranno essere proposte dalla tecnologia. 3) In tutta l’opera, il papa si sofferma soprattutto su due temi: necessità di un impegno corale profondamente affratellante; necessità di un cambiamento radicale e sostanziale di “stili di vita, di produzione e di consumo” da parte dell’intera umanità. 4) Interessantissimo è il suo evidenziare con grande tenacia ( ben combinando insieme istanze umanistiche e illuministiche, per tanto tempo duramente combattute dalla Chiesa) l’inscindibile connessione sussistente fra micro e macro-cosmo, cogliendo un rapporto di indissolubile corrispondenza tra la felicità dell’essere umano e la salute dell’ambiente in cui esso si trova a vivere, sostenendo inoltre, come ineluttabile conseguenza, l’intima connessione fra “il degrado ambientale e il degrado umano ed etico” 5).
 Un vero “approccio ecologico”, secondo il pontefice cattolico, è chiamato a farsi anche “approccio sociale”, integrando “la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri”, 6) di quegli esclusi, cioè, che costituiscono la maggioranza della popolazione mondiale. Di quegli esclusi che sono vittime di quei poteri economici, finanziari e politici che continuano follemente “a giustificare l’attuale sistema mondiale, in cui prevalgono una speculazione e una ricerca della rendita finanziaria che tendono ad ignorare ogni contesto e gli effetti sulla dignità umana e sull’ambiente.” 7)
Un vero “approccio ecologico”, secondo il pontefice cattolico, è chiamato a farsi anche “approccio sociale”, integrando “la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri”, 6) di quegli esclusi, cioè, che costituiscono la maggioranza della popolazione mondiale. Di quegli esclusi che sono vittime di quei poteri economici, finanziari e politici che continuano follemente “a giustificare l’attuale sistema mondiale, in cui prevalgono una speculazione e una ricerca della rendita finanziaria che tendono ad ignorare ogni contesto e gli effetti sulla dignità umana e sull’ambiente.” 7)
Di eccezionale bellezza e importanza concettuale è quanto il papa asserisce nel primo paragrafo del secondo capitolo, intitolato La luce che la fede offre 8). Qui, dalla constatazione “della complessità della crisi ecologica e dalle sue molteplici cause” si ricava la convinzione che le possibili soluzioni non potranno provenire “da un unico modo di interpretare e trasformare la realtà” 9) e che, di conseguenza, sarà necessario fare riferimento “alle diverse ricchezze culturali dei popoli, all’arte e alla poesia, alla vita interiore e alla spiritualità” 10), non trascurando “nessun ramo delle scienze e nessuna forma di saggezza”, ivi inclusa quella religiosa 11).
Ci troviamo di fronte ad un atteggiamento di apertura davvero entusiasmante. Il papa, infatti, non si limita a mettere in discussione posizioni di stampo positivistico (cosa questa senz’altro prevedibile), ma arriva anche a conferire grande dignità (potremmo quasi dire “pari dignità”) alle varie esperienza culturali e alle varie forme di saggezza filosofiche e religiose che si sono potute esprimere all’interno dei vari cammini storici dei tanti popoli del mondo, rinunciando così a presentare il Credo cattolico come unica fonte di verità e come unica soluzione a tutti i problemi dell’esistenza umana.
E, dopo aver ribadita la piena disponibilità della Chiesa cattolica (attuale) al dialogo con il pensiero filosofico, sottolinea la doverosità di “un dialogo con tutti per cercare insieme cammini di liberazione”.
In parole come queste si riflette quanto di meglio hanno saputo esprimere la migliore cultura laica e la migliore cultura religiosa d’Occidente come d’Oriente. Si riflette il pensiero dei grandi maestri che hanno insegnato e praticato la tolleranza, il superamento delle chiusure e degli arroccamenti egocentrici e di ogni settarismo (palese e celato), da Socrate a Plotino, da Meister Eckhart a Erasmo da Rotterdam, da Spinoza a Voltaire, da Helena Petrovna Blavatsky a Krishnamurti, da Gandhi ad Aldo Capitini. Quelle due parole usate da papa Francesco, infatti, “cercare insieme” (aprendosi al dialogo), sembrano voler rinnegare i quasi 1.700 anni di Chiesa costantiniana, teodosiana e tridentina, caratterizzati da arrogante presunzione di superiorità assoluta (anzi di assoluta unicità), da superba pretesa all’infallibilità, al monopolio di verità rivelate, considerate come l’unica via meritevole di essere percorsa, in quanto indicata dalla stessa Sapienza divina ( come tale indiscutibile e irrinunciabile).
Parole rese ancora più forti ed eloquenti dalle successive altre due: “cammini di liberazione”. Qui sembrerebbe davvero chiara la volontà di questo papa “venuto da lontano” di far scendere il cattolicesimo in mezzo ai “tutti”, ponendosi al fianco dei “tutti”, a servizio dei “tutti”, senza più porsi come centro unico e assoluto della storia umana, chiamato a giudicare, anatemizzare, scomunicare, assolvere, condannare, convertire i “tutti” …
Trovo meraviglioso, in particolare, l’uso fatto del plurale: “cammini” e non “cammino”. Un plurale che si colloca lontano anni luce dalla rigida e autoritaria Chiesa di Pio XII, come da quella trionfalistica (e non certo meno autoritaria) di Giovanni Paolo II. Un plurale che sembrerebbe poter essere inteso come piena accettazione di valori tanto caparbiamente negati e disprezzati dalla Chiesa di ieri, valori come libertà di pensiero, libertà di coscienza, libertà di credo filosofico e religioso, ecc …
Cammini da ricercare, sperimentare, esaminare, discutere, integrare, correggere, confrontare, migliorare, sviluppare attraverso lo scambio, facendo tesoro degli sforzi altrui e della ricchezza morale e culturale di tutti. Aspirando ad una “liberazione” che è traguardo di tutti, di nessuno escluso, che riguarda gli esseri umani in quanto tali, al di là delle bandiere amate, degli altari venerati, dei dogmi abbracciati, dei rituali praticati.
E ancora più bello è forse quanto poi il papa aggiunge, dicendo che, benché l’Enciclica sia aperta al “dialogo con tutti per cercare insieme cammini di liberazione”, suo obiettivo sia mostrare come “le convinzioni di fede offrano ai cristiani, e in parte anche ad altri credenti, motivazioni alte per prendersi cura della natura e dei fratelli e sorelle più fragili.”
 In pratica, si vuole far capire ai cristiani (ma anche ai non cristiani) che dalla giusta comprensione (che fino ad ora è evidentemente mancata!) e dalla coerente attuazione della dottrina cristiana non potrà che derivare “un bene per l’umanità e per il mondo” intero. 12) E non si può certo sottovalutare che si parli di “motivazioni alte”, non delle uniche possibili e legittime, o, comunque, delle più alte. Simili, quindi, a quelle che potrebbero essere ravvisate e attinte altrove, in altre fedi e in altre religioni (in altri “cammini”).
In pratica, si vuole far capire ai cristiani (ma anche ai non cristiani) che dalla giusta comprensione (che fino ad ora è evidentemente mancata!) e dalla coerente attuazione della dottrina cristiana non potrà che derivare “un bene per l’umanità e per il mondo” intero. 12) E non si può certo sottovalutare che si parli di “motivazioni alte”, non delle uniche possibili e legittime, o, comunque, delle più alte. Simili, quindi, a quelle che potrebbero essere ravvisate e attinte altrove, in altre fedi e in altre religioni (in altri “cammini”).
Importanti perché tali da spronare a farsi carico responsabilmente dei problemi dell’intera realtà vivente, occupandosi e preoccupandosi, in particolar modo, “dei fratelli e sorelle più fragili”.
Difficile davvero, a questo punto, pensare che il mondo animale, vessato e torturato in mille modi dalla umana avidità e stoltezza, possa non meritare di essere anch’esso accolto nell’ambito di questa grande famiglia.
Come poter non includere, infatti, all’interno delle esistenze “più fragili” da difendere e tutelare anche le creature a cui il santo di Assisi amava predicare?
Ma come potranno, mi chiedo, i milioni di fedeli di Santa Madre Chiesa rispettare il fermo e inequivocabile invito della propria guida apostolica a prendersi cura della natura e delle sue creature, continuando a praticare spensieratamente la mattanza planetaria di masse sterminate di esseri (terribilmente fragili) destinati a finire sulle loro tavole?
Sapranno i cattolici accogliere questa esortazione? Sapranno rinnegare il carnivorismo come sono riusciti (seppur molto faticosamente e parzialmente) a rinnegare tanti altri crimini e misfatti del proprio passato?
NOTE
Papa Francesco, Laudato sì. Sulla cura della casa comune, San Paolo Edizioni, 2015, P.37
Ibidem
Ib
P.45
P.68
P.62
P.68
P.73
Ibidem
Ib
P. 73-4
P.74